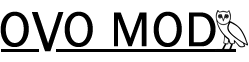«Le coprivo con un sacco di cose: gioielli, stivali… eppure erano così sexy le mie donne». Non si può dire che Alber Elbaz sia un fiume
In un pomeriggio di giugno a Milano, sta seduto tranquillamente al Grand Hotel et de Milan dopo una toccata e fuga in città per uno dei tanti incontri cui si sta dedicando: non per ricevere offerte di lavoro, dice, ma per sviluppare idee e progetti dei quali accenna soltanto, e che così rimangono sexy e misteriosi come le sue donne.
Le sue donne erano sexy perché stimolavano l’immaginazione?
Un semplice décolleté è in fondo un trucco, mentre sotto i miei abiti diventavano forti, perfette per uomini potenti. Prima di continuare la conversazione, Elbaz ha una domanda importante da farmi. Perché proprio io? È una cosa che mi ha messo un po’ di ansia. “Vogue Italia” è sempre stata una rivista sul successo e il trionfo.
Perché siete venuti a cercare me, che invece adesso sono in disparte?
Credo che al direttore non interessasse una “success story”, ma un punto di vista diverso da parte di uno come lei che in questo momento si può permettere di guardare con un po’ di distanza il mondo della moda e capire meglio dove sta andando. È vero, mi interessa il “next”, cosa accadrà domani.
Le piace fare interviste?
Ne ho fatte tante. Le migliori sono quelle che ti sbucciano come una cipolla, le peggiori quelle che ti friggono.
Cosa attira la sua attenzione di questi tempi?
Le storie più che le immagini. Mi sto facendo un sacco di domande da solo. Tipo: la moda deve per forza essere legata al potere o può essere anche piccola e modesta? Stiamo vivendo in un momento di enormi cambiamenti e il sistema non sempre funziona. I social media hanno mutato la nostra vita.
Quindi?
Quindi osservo con molta attenzione la tecnologia e vedo che si muove sfruttando i cambiamenti, mentre la moda lo fa in un modo molto limitato. Siamo passati da una clientela esclusiva a un’esclusività alla portata di tutti. Questo ha portato alla destabilizzazione del sistema. Il tempo per riflettere è diminuito drammaticamente; un tempo la creatività era legata agli eccessi, alcol, droghe eccetera, oggi è legata all’healthiness, allo stare bene, alle diete, alla moderazione. Insomma, la creazione è diventata ricreazione.
Che cosa cerca dunque?
Cerco risposte che mi possano fare pensare alla moda attraverso la tecnologia. E non intendo certo abiti con sensori che ti dicano quando hai freddo, fame o paura. Alla tecnologia chiedo piuttosto se è possibile creare un tessuto con le stesse tonalità che troviamo oggi sullo schermo di un computer, scoprire nuovi colori impensabili, nuove forme. Ma c’è un’altra cosa che la moda usa poco, oltre alla tecnologia: il senso dell’umorismo. Non tanto il saper ridere di se stessa, quanto l’essere capace di far sorridere un po’ gli altri.
Il mestiere dello stilista è diventato più difficile?
Certamente meno prevedibile, come d’altronde la politica, o l’arte. Prima si disegnava una collezione pensando a quei 300 editor che stavano in cima al sistema. Era molto difficile, ma si sapeva cosa si doveva fare e quali erano i limiti della sfida. Oggi tutto esce senza filtri, in tempo reale. Certo, c’è sempre la recensione del critico potente, ma poi arriva il responso dei milioni che navigano sui social. È come un talent show: c’è la giuria, ma poi è il pubblico che vota.
Qual è la parola che definisce meglio il momento?
Comfort. Ma non mi fraintenda: non nel senso di abiti comodi, ma di una moda che ti faccia stare bene con te stesso. Penso a Steve Jobs. Quando si analizzava il suo modo di vestire si diceva che era un fashion statement. Sbagliavamo. I suoi abiti rivelavano la necessità di stare bene con se stesso per poter pensare e creare meglio.
Un altro esempio?
A gennaio guardavo su Instagram le immagini delle donne che marciavano per protesta contro Trump a Washington e allo stesso tempo quelle delle collezioni di alta moda a Parigi. Ho pensato che finalmente le donne possono marciare e sognare al tempo stesso: non c’è più necessità di lasciar perdere una cosa per l’altra.
E per lei dov’è la comfort zone?
Nei musei. Mi sono chiesto perché la gente si mette in fila per entrare nei grandi musei. Per i coffee shop? O per l’aria condizionata, come succedeva a mia madre che andava in banca d’estate perché faceva fresco? No. La gente ci va perché al museo alla fine nessuno tenta di farti il lavaggio del cervello. È l’unico luogo dove regna l’armonia, dove ieri e domani non sono in guerra. E quando c’è armonia uno sogna.
Cosa sogna Elbaz?
L’altro giorno ho sentito Papa Francesco dire di non costruire muri, ma ponti. Sogno di costruire un ponte fra tecnologia e moda. Una fabbrica di sogni. Perché senza una fabbrica i sogni non si possono realizzare, ma senza un qualche sogno nessuna fabbrica può davvero funzionare.
Come si sente in questo anno sabbatico?
Sabbatico?!? Non sono mai stato in un anno sabbatico. Sono stato in un deserto per un anno dove mi è venuta molta sete.
Sete di un nuovo impegno?
No, sete di un nuovo racconto. Poter raccontare qualcosa di nuovo.
Cosa fa più paura all’industria della moda, oggi?
I Millennials! Oddio! Cosa mai ne penseranno i Millennials? Poi uno guarda le statistiche e vede che il settanta per cento dei clienti è composto da donne sopra i cinquant’anni. Macron e sua moglie sono un bell’esempio di come diverse generazioni che s’intrecciano possano creare una realtà molto autentica e più concreta.
Qual è la sua principale qualità come stilista?
Molti anni fa Suzy Menkes mi definì un maestro dell’improvvisazione. Ci rimasi molto male. Ma come, uno lavora giorno e notte, poi il risultato viene considerato un’improvvisazione? In realtà aveva ragione da vendere. L’improvvisazione è alla base della ricerca e degli esperimenti. Quando uno ha il caviale in frigorifero e gli arrivano degli ospiti non ha bisogno d’improvvisare, ma se non c’è niente in frigorifero l’improvvisazione è essenziale. Improvvisare vuol dire scoprire. Questo è il problema di tanti giovani nelle accademie di moda: usano Google in ogni modo possibile, cercano, ma non scoprono, così non trovano la propria voce.
Quali erano i suoi sogni da ragazzo?
Sono cresciuto in una grande famiglia a Tel Aviv e sognavo di fare il dottore. Ma non un luminare della medicina, un dottore normale come quello di Madame Bovary. M’interessava toccare direttamente il corpo da punti di vista diversi. Credo che alla fine quello che sono finito a fare, e che vorrei continuare a fare, è proprio questo: toccare il corpo da tante prospettive diverse. Può dirmi quali progetti sta seguendo in questo momento? Parlo con molte persone, esploro molte idee e devo dire che voi italiani siete quelli che rispondono di più alle mie fantasie. Non è un caso che sia qui a parlare con “Vogue Italia”. Non mi sono ancora innamorato di niente, ma prima o poi capiterà l’occasione.
Se dovesse darsi adesso una definizione?
Mi sento come Galileo Galilei (ride, ndr). Sto guardando qualcosa che c’è, ma che gli altri ancora non conoscono, o non vedono. Sto lavorando tanto per andare oltre la moda senza perdere rispetto per la moda.
Il mondo della moda consuma?
Quando uno pensa di essere favoloso è l’inizio della fine, magari è già finito tutto e non ce ne siamo accorti. Quindi… …Quindi nella mia famiglia di solito non ci siamo mai sentiti particolarmente belli o attraenti, ma un giorno mi capitò fra le mani un album con delle vecchie fotografie: sembravamo tutti magnifici! Allora chiamai mia madre e le dissi: «Ma perché dite sempre che non siamo belli, eravamo fantastici!». **Ecco, la prospettiva che ti dà il tempo porta anche un po’ più di verità e disponibilità. Il giudizio del tempo è più dolce. **
Francesco Bonami, Vogue Italia, luglio 2017, n.803, pag.208