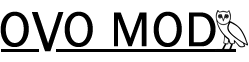Susannah Clapp, oggi critica letteraria e teatrale, fondatrice della London Review of Books, negli anni Settanta faceva l’editor dall’editore Jonathan Cape a Londra e un
La casa di Pisé, in Mali.
Chatwin non era poi un vero esordiente: «C’era stato un manoscritto enorme sul nomadismo a cui aveva lavorato anni prima, ma che non era mai andato in porto». Chatwin, sostiene Clapp, «non si considerava un autore, piuttosto appunto un giornalista, oltre che naturalmente un esperto d’arte». E per fortuna (della Clapp, e nostra di lettori), «l’editing gli piaceva molto, non aveva problemi a tagliare interi capitoli, e il giorno dopo si ripresentava con uno nuovo scritto la notte. Aveva uno stile quick e conciso, che gli derivava anche dall’aver scritto un’infinità di voci per cataloghi d’arte». Quando si presenta alla Clapp era giovane, ma aveva già un passato: a Sotheby’s, dove era andato a lavorare a 18 anni, «era una star: aveva un occhio veloce per i falsi, e un occhio altrettanto sicuro per ciò che era buono e vero. Era anche destinato a incantare i clienti nell’acquisto e nella vendita». Leggendaria una visita a Somerset Maugham in Costa Azzurra, «per schedare la collezione di impressionisti dello scrittore»; che però amava accarezzare soprattutto la testa bionda del giovane esperto («i suoi superiori a Sotheby’s lo sapevano e gli avevano raccomandato di andare con lo shampoo fatto», ha scritto la Clapp nel racconto di quella collaborazione, e amicizia, Con Chatwin, Adelphi). A lui piaceva provare tutto, ma si annoiava in fretta. «Lasciò la casa d’aste per andare all’Università di Edimburgo e studiare archeologia. Ma anche lì se ne andò dopo soli due anni senza laurearsi». A trent’anni, era stato preso al Sunday Times Magazine dove scriveva profili come quello di Ernst Jünger, suo idolo, che corteggiò (era soprattutto un eccezionale corteggiatore) così: «Caro Herr Jünger, il Sunday Times ha una tradizione di interviste a grandi europei – io personalmente ho appena fatto André Malraux a Parigi. Il mio tedesco è rudimentale, ma so che il suo francese è splendido. Potrei avere l’onore di intervistarla?». Quello ovviamente ci casca, e ne viene fuori un incipit notevole: «Abbiamo di fronte un uomo nel bel mezzo dell’occupazione di Parigi con i bombardieri che gli volano sopra la testa e lui se ne sta sul tetto con lo champagne in mano a fare piccole osservazioni».
Maria Reiche, matematica e geografa tedesca che ha dedicato la sua vita allo studio delle linee di Nazca nella Pampa de Ingenio.
Non si sa se sia stato un grande scrittore, di sicuro ha inventato uno stile, Chatwin, essenziale e scarno e godibile, che invecchia benissimo sulla pagina: «I suoi modelli di riferimento erano Byron, Flaubert, Hemingway, Noël Coward», dice Clapp. Era decisamente un funzionalista: tutto ciò che poteva essere tolto andava tolto. «Lo si vedeva anche dai pezzi che aveva nel suo appartamento, non necessariamente quadri ma oggetti curiosi con una storia. Straordinari manufatti, che avevano una funzione precisa, come un vassoio utilizzato dai pescatori di Istanbul per deporre il pesce». Ha generato eredi, Chatwin? «Molti si ispirano a lui, però non saprei, no, neanche mi interessa», dice la Clapp, forse con nostalgia.
In Patagonia (luogo che dovrebbe fargli una statua, anche se sarebbe subito abbattuta, oggi), Chatwin c’era andato per Eileen Gray, altra sua eroina che condivideva come lui l’odio per la decorazione; l’anziana designer irlandese, a Parigi «abitava a Rue Bonaparte, e nel suo salotto era appesa una carta della Patagonia, dipinta a tempera». «Ho sempre desiderato andarci», le disse Chatwin. «Anch’io», rispose la Gray. «Ci vada per me». Andò, e telegrafò al Times. «Andato in Patagonia».
«In Patagonia avrebbe poi ridefinito l’idea di libro di viaggio pieno di frammenti su incontri, racconti personali, ricordi. Tutti in apparenza slegati tra loro. Era una specie di libro cubista, un’espressione che a Bruce piaceva molto», dice la Clapp, che ha assistito Chatwin anche nel secondo libro (Il viceré di Ouidah) e poi nell’ultimo, Utz, «che scrisse quando stava per morire».
(Continua)
English text atthis link.
In apertura: Bruce Chatwin nell'Hindu Kush, nel 1964.
Tutte le immagini: foto di Bruce Chatwin e David Nash, dal libro L’occhio assoluto - Fotografie e taccuini, Adelphi/di Bruce Chatwin (“Bruce Chatwin: Photographs and Notebooks”, prima edizione inglese pubblicata da Jonathan Cape). Courtesy di Bruce Chatwin Estate e Adelphi Edizioni.