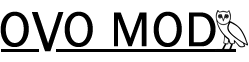450.300.000/1*
di Francesco Bonami
La filosofia di Loïc Gouzer è: ne basta una. Quando era a capo del dipartimento di arte contemporanea di Christie’s, a
Uno solo è stato il misterioso acquirente del quasi Leonardo, il “Salvator Mundi”, che lo stesso Loïc Gouzer aveva al telefono quella sera del novembre 2017 e che ha speso 450,3 milioni di dollari per fare un regalo, pare al principe ereditario saudita, il feroce MBS.
Uno è il numero che Gouzer ha capito funzionare meglio sul mercato dell’arte perché non dà scelta, non dà incertezze, non consente vie d’uscita. Ora: non si trova né un Leonardo tutti i giorni, né uno sceicco disposto a farsi trafiggere dall’unico colpo in canna a disposizione di questo ragazzo che potrebbe benissimo essere uscito da un film francese degli anni 60. Una sorta di Belmondo del mondo dell’arte. D’altronde le sue scorribande nel mercato delle aste sono sempre state À bout de souffle, all’ultimo respiro, come il famoso film di Jean-Luc Godard. Così Gouzer ha capito che forse non era il caso di rischiare troppo con i numeri uno delle case reali.
Lasciata Christie’s si è messo in proprio e la sua nuova avventura non poteva che essere focalizzata sempre e soltanto sul numero 1. La sua app Fair Warning, mitica frase che il battitore pronuncia prima di sbattere il martelletto, consiste nel mettere in vendita ogni settimana un solo pezzo, esclusivo. Non si può però essere uno qualsiasi per partecipare all’asta e fare la propria offerta sul pezzo unico. Bisogna essere accettati da lui, Gouzer, che da solo ricopre tutti i ruoli della casa d’aste, da fattorino a Ceo, a battitore. Non solo, poiché sulla app non si vedono gli altri contendenti, la sfida si riduce a uno contro uno. Una sfida all’Ok Corral tra ipotetico acquirente e solitario venditore.
Se i 450,3 milioni avevano, nella loro esagerata quantità, dato alla testa di Gouzer come i ventiquattro vodka martini bevuti l’uno dopo l’altro (probabilmente per festeggiare), passata la sbornia il selvaggio Loïc deve aver pensato dell’operazione Leonardo la stessa cosa di Belmondo nell’ultima scena di À bout de souffle: «C’est vraiment dégueulasse», fa veramente schifo. Così, ritiratosi nel suo garage di Montauk a Long Island, ha capito che dopo essere arrivato a quasi mezzo miliardo la cosa migliore e più intelligente sarebbe stata ripartire da 1.
Numero simbolico, a prescindere dalle aste, per tutto il mondo dell’arte, che ha visto azzerare per la pandemia i propri affari. Arrivati a 450,3 milioni – i fatti dimostrano – può solo andare peggio.
Da 1 si può solo migliorare. I primi risultati dell’asta app lo confermano. Attenzione! Fair Warning! O la va o la spacca! È la legge del numero 1 di Gouzer.
* 450,3 milioni di dollari: il prezzo pagato per il Salvator Mundi attribuito a Leonardo. 1: da qui riparte il mercato dell’arte.
Artwork for 62,2%
62,2*
di Fabiana Giacomotti
«Ma io compro a mia figlia tutto quello che vuole, perché mai dovrei assegnarle una paghetta?».
Il gender gap sul denaro, certificato da un dato dell’annuale ricerca Episteme- Intesa Sanpaolo da cui emerge che il 21 per cento delle donne italiane non ha un conto bancario personale e che il 9 per cento (sono circa due milioni, non poche) non ha la firma su alcun conto, nasce lì, in famiglia.
La ritrosia a occuparsi dei soldi, addirittura a parlarne, mette radici nei comportamenti di padri e di madri anche di ottimo livello socio-culturale che però, candidi, ammettono di affidare piccole cifre settimanali ai figli maschi «perché imparino a occuparsene», ma di non ritenere affatto necessario dover procedere nello stesso modo con le figlie, avviandole di fatto a una carriera di questuanti a vita o, peggio – e il nodo è tutto qui –, continuando a perpetuare l’idea del maschio salvifico, del principe azzurro che elargisce doni, prebende, sicurezza materiale e, va da sé, sentimentale.
Dunque, non deve stupire che nel Paese dove le ragazze superano i coetanei maschi nei risultati accademici, sia numericamente sia nei voti, al momento di metterli a frutto per la propria indipendenza si facciano cogliere da timori oppure da quel suo derivato autoprotettivo che è la noia: il denaro come tema noioso, da delegare “all’uomo di casa”. «Dai nostri sondaggi emerge che anche quando le donne pensano di rappresentare la figura manageriale di riferimento in famiglia – il che accade nel 40 per cento dei casi – in realtà si occupano delle spese quotidiane, di certo non di assumere decisioni di medio-lungo termine sugli investimenti», osserva la direttrice del Museo del Risparmio di Intesa, Giovanna Paladino, che in questi mesi ha lanciato un progetto phygital (tra fisico e digitale) a sostegno dell’indipendenza economica femminile su scala nazionale (#promettodiprendermicuradimestessa).
Il lavoro o la sua mancanza, che pure è una piaga sociale nell’Italia dove meno della metà delle donne ha un impiego e ancora nel 2019 37mila neomamme hanno ritenuto indispensabile licenziarsi, non è dunque il fattore determinante, la ragione che impedisce l’educazione e la crescita della conoscenza finanziaria femminile: la causa va piuttosto ricercata negli stereotipi culturali che partono dalla famiglia italiana.
La demonizzazione della ricchezza e di chi fa soldi, tipica della cultura cattolica, si riverbera anche sui comportamenti delle classi più istruite: il 59,4 per cento dell’universo femminile percepisce un reddito, ma solo il 37,8 per cento è completamente indipendente economicamente. E così accade che, al momento di un’eventuale separazione, molte donne non sappiano dire dove e come siano investiti i soldi di famiglia, o che i legali ai quali si rivolgono trovino dopo molte ricerche conti svuotati e investimenti volatilizzati. La dipendenza finanziaria può costare carissimo, sia durante il matrimonio, dove tende inevitabilmente a trasformarsi in sudditanza psicologica, sia, in caso, dopo.
«Il nostro Paese sconta un retaggio culturale che carica le donne di false aspettative rispetto ai coniugi, di lavoro domestico e di cura della famiglia, scoraggiando di fatto la ricerca di un lavoro e la crescita professionale». E la fase Covid, purtroppo, non ha fatto che confermarlo.
*Percentuale di donne italiane non indipendenti economicamente.
Artwork for 20
20*
di Michele Masneri
20 anni fa, era il 2000, Philip Roth pubblicava La macchia umana (Einaudi), storia di un professore d’università frainteso, accusato di razzismo, dunque espulso da un mondo accademico sempre più dominato dalla “cancel culture”, che all’epoca non si chiamava ancora così. Oggi in Italia si discute animatamente – e seriamente – di “dittatura del politicamente corretto” senza che vi sia mai stato nulla del genere nel nostro Paese. Il problema è che i social media ci hanno dato l’illusione di essere tutti – non solo individui ma anche Paesi – sullo stesso piano: 1 vale 1, dunque se sto seguendo un dibattito tra intellettuali newyorkesi, io sarò certamente parte di quel dibattito. Invece, il ritardo continua, e si sente.
La gita a Chiasso che invocava Alberto Arbasino per svecchiare la cultura italiana (attraversare la frontiera, accaparrarsi testi che non arrivassero, mal tradotti, appunto con 20 anni di ritardo) oggi vale ancora. Il lamento dell’italiano medio sui temi delle minoranze, del rispetto dei diritti, è tragicamente sincero e in buona fede nel suo essere completamente d’epoca: adesso arriverà questo politicamente corretto e spazzerà via tutto, questo il lamento del boomer, il boomer’s complaint. Ma è il solito modo italiano di segnare 2 volte al giorno l’ora giusta: un Paese che ha avuto gli antidivi senza avere i divi, il senso di colpa per il successo senza il successo, la critica al neoliberismo senza mai un briciolo di neoliberismo.
Così, mentre gli altri Paesi e soprattutto l’America si interrogano sulle potenziali difformità e derive del “pc” – mentre Shakespeare viene escluso dai testi universitari e Via col vento dotato di spiegoni forse superflui –, l’italiano medio teme soprattutto, sentendosi così privato di sue fondamentalissime libertà, di non poter più dire la parola con la F o la parola con la N (fingiamo qui di essere in America: su un giornale italiano entrambe le parole si possono tranquillamente, ancora, pubblicare). Invece, bizzarramente, da noi non si può scrivere la parola con la M, così si può leggere: aggrediti due ragazzi, al grido di: «F di M», dove M ha gli asterischi. Siamo originali anche in questo.
E non è che siamo un popolo di retrogradi, né di razzisti. Siamo, forse, solamente vintage: con questi 20 anni (stando stretti) che ci separano dalle best practice di Paesi più evoluti. Così risultiamo simpatici, con gli amici americani in visita, che ci dicono: ah, che bravi, avete finalmente sgominato Uber, siete tornati ai vecchi taxi. Vagli a spiegare che Uber non è ancora arrivata. Ma forse è il segreto del nostro successo, insieme all’Italian style, al cappuccino e alla dieta mediterranea.
Ancora quelle belle discussioni sul Gay Pride con le tette al vento («Io ci giravo già 20 anni fa», cantava Guccini 40 anni fa), mentre nel primo mondo si chiama solo Pride da un bel po’, e preoccupa piuttosto per l’eccessiva aziendalizzazione, con tutte le grosse corporation a sponsorizzare i meglio carri (vedrete che rimpianti, quando anche il capufficio dovrà salire sul carro in giacca e cravatta, col caldo che fa. Ma sarà comunque tra 20 anni, non prima. C’è tempo).
* Sono 20, secondo l’autore, gli anni di ritardo che l’Italia sconta nel dibattito sul politically correct.
(continua)
Leggete gli altri testi, di David Leavitt, Steven Pinker, David Quammen, François-Henri Pinault, Sarah Mower, Kimberly Drew, Tara Donaldoson, Lea T e Naymare Azevedo, Tahar Ben Jelloun, nel numero di Vogue in edicola dal 28 agosto