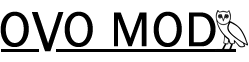A trentadue anni, l’irlandese Roisin Kiberd è una veterana di Internet e non una qualsiasi: è come se fosse sopravvissuta a due guerre mondiali, al Vietnam
In quale comunità online si è sentita più frustrata?
Ogni piattaforma generalista offre la sua tristezza particolare, anche se tutte portano all’inazione, sfruttando i sogni degli utenti. Più che connettere, espropriano esperienze. Intrappolati, siamo noi a fornire la benzina con cui funzionano. Lo sappiamo ma restiamo, il che produce un’ambivalenza dolorosa. Leggendo i pareri di chi lo usa molto, Twitter sembra un circo infelice in cui ripetere all’infinito gli stessi pareri. Su Facebook si va per confermare i propri sospetti e avere ragione. L’effetto comune è cancellare la nostra idea di futuro. Immaginarlo così diventa innaturale, perché ci pensano le piattaforme sulla base delle nostre scelte, di quanto già scritto, condiviso.
Un’immagine di Peyton Fulford tratta dalla serie “Infinite Tenderness”. «Questo lavoro documenta la messa in discussione del proprio corpo, sessualità e identità, che ognuno di noi sperimenta crescendo e formandosi», spiega. «La mia intenzione è quella di creare uno spazio in cui i ragazzi queer, magari cresciuti in piccoli paesi come il mio, possano riconoscersi e accettarsi»
© csu
Con quale conseguenza?
Snaturare la verità. Non è un caso che la mia crisi sia esplosa nel 2016, anno delle fake news. Mi arrivò una email da Instagram: diceva che, da quel giorno, sapevano di me più di quanto sapessi io e mi avrebbero mostrato solo ciò che mi piaceva. Se si estrae il tempo dai binari della Storia, gli eventi tornano, non viviamo una cronologia ma dentro una timeline artificiale che mescola passato e presente.
Lei scrive: «In un mondo costruito su ciò che è familiare, non c’è nulla da imparare». Cosa significa?
Io sono femminista, ma se leggo che cosa si dice su questo tema nei social, sono delusa. È una recita accorta di posizioni ideali e non c’è certezza di come, chi scrive, possa agire nella realtà. Le piattaforme sono alla ricerca dell’utente ideale. Il sogno di Facebook è il “normcore”. Qui tutto deve essere approvabile, comprensibile. Ciò obbliga ad avere un giudizio nell’immediato, scegliendo tra bianco e nero, quando noi viviamo sfumature di grigio. Costretti a una performance, il proprio stile deve essere promosso come un brand, modellato per essere amati, mentre a noi servono idee che non necessitino approvazione. Profili lineari, igienizzati, uguaglianza obbligata: è violenza.
Associa l’esperienza online all’immagine delViandante sul mare di nebbiadi Friedrich. «Perso in contemplazione, davanti alla barra di ricerca di Google... Per sempre solo». È la solitudine, la maledizione dei social?
Sì, e il tipico consiglio per curarla è di avere più amici, il che crea un effetto paradossale, perché non è il numero a regalare una vita migliore. Internet è la tecnologia della solitudine.
(Continua)