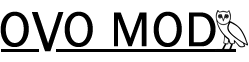Mai dimenticato da un manipolo, negli ultimi tempi in lento ma costante aumento, di affezionati cultori e collezionisti Guy Harloff continua a essere una figura del
Guy Harloff a bordo di Le Devenir. Foto courtesy Giovanni Ricci.
Un velo di mistero e di leggenda ammanta tuttora la singolare figura di Guy Harloff. Nato a Parigi nel 1933 da padre olandese (con origini russe) e madre svizzera, ha abitato ovunque: in Ungheria (da bambino), a Londra, New York, Milano, Venezia, ma anche in Marocco e Medio Oriente... Definito “esploratore insaziabile” dal critico Patrick Waldberg, il suo bisogno di autonomia e di rivelazioni ne ha sempre improntato il percorso umano e artistico, conducendolo su sentieri inesplorati. Avvinto dalla baudelairiana avventura “spleenetica”, prepotentemente, dannatamente bisognoso di abbeverarsi dei misteri della vita, ha coltivato un’idea mistica e sacrale dell’arte, rimanendo – nonostante le numerose mostre internazionali – un puro che rifiutava di entrare nel sistema istituzionalizzato. Ciò che a lui interessava era avere il necessario per potersi dedicare ai molteplici interessi che la sua sbrigliata curiosità inseguiva: la psicanalisi, le culture orientali, la tradizione taoista e sufista, gli studi alchemici e animisti...
All'ormeggio a Chioggia. Foto courtesy Giovanni Ricci.
«Lavoro da quasi trent’anni», scriveva nel marzo 1983. «Forse non ho ancora iniziato veramente. La pittura, come estetica, fatto culturale o di moda, non mi interessa. È solo un metodo, un veicolo come un altro per arrivare a una conoscenza di sé, a una realizzazione». La prima esperienza che lo portò a plasmarsi un luogo tutto suo («randagio stufo di spostarsi», lo disse Giovanni Arpino), dove convivere con i libri che lo avevano formato, la musica che lo accompagnava mentre dipingeva, gli strumenti del mestiere, fu l’imbarcazione che si costruì in parte da solo e che, tra la fine degli anni Sessanta e i primi Settanta, divenne la sua unica “fissa dimora”, ormeggiata a Venezia e poi a Chioggia. «Le barche, le navi, sono il grande viaggio», scrisse. “Le Devenir” fu il nome che scelse per questa casa mobile. Un nome che serbava in sé, affermava e rammentava il bergsoniano “élan vital”, poiché l’esistenza deve essere incessante novità, creazione, imprevedibilità, realtà sempre nuova che, inglobando e conservando l’intero passato, cresce su se stessa. Su Le Devenir – un peschereccio di legno, come ricorda l’amico fotografo Giovanni “Johnny” Ricci, al quale dobbiamo le foto di queste pagine e lo scatto (con relative ristampe) dell’occhio destro dell’artista che ci scruta da tutti i suoi lavori – il pittore risiedeva con la compagna Maggie Ray, l’inseparabile, letale bottiglia di whisky e gli amatissimi cani. Gli spazi angusti e minimali lo erano ancor più per un uomo di oltre due metri d’altezza e centoventi chili di stazza. Si mangiava nella cabina di pilotaggio.
Guy Harloff e Maggie Ray a bordo di Le Devenir. Foto courtesy Giovanni Ricci.
Il luogo sacro era il tavolino da lavoro. In questo microcosmo, fatto di ricercata essenzialità, Harloff era però in grado di confinare tutto se stesso e il proprio sterminato universo. Un ossimoro come l’intero suo cammino. E, come per molti aspetti della sua inquieta esistenza, anche la fonte di un rapporto di amore-odio: «Una barca è la peggior catena che un uomo si possa legare intorno al collo», scriveva. «Uno ne diventa letteralmente schiavo. La barca è sempre in avaria o in riparazione. C’è sempre qualcosa che non funziona, e i soldi filano via che è una meraviglia». Tra arrabbiature, piccole crociere, lunghi ormeggi, l’esperienza nautica di Harloff si chiuse in pochi anni.
Il critico Harald Szeemann sullo scafo in costruzione. Szeeman invitò Harloff a Documenta 5 nel 1972. Foto courtesy Giovanni Ricci.
E tuttavia, una volta venduta la barca, l’artista tornava negli States per girarli in lungo e in largo con un altrettanto coercitivo (e claustrofobico) camper Volkswagen. Ricordando i tanti anni trascorsi da Harloff in minuscole camere d’affitto e hotel di bassa lega, si è portati a concludere che, per lui, il luogo dove si trovava il suo atelier fosse, in fondo, un fattore secondario. L’arte è pensiero, studio, ma anche lavoro concreto, artigianale, maniacalmente curato in ogni dettaglio, forma, colore. E le opere del pittore, per un rapporto inversamente proporzionale alle misure dell’autore, sono eleganti miniature in cui si accavallano le tecniche, in cui si insegue una misurata armonia di simboli, ideogrammi, parole, accostati in fantastiche architetture cromatiche e segniche. Ecco perché il suo studio poteva trovarsi in ogni dove, in una camera d’albergo come su un peschereccio o un pulmino. Erano sufficienti un piccolo tavolo e pochi strumenti. I suoi lavori, data l’intima ricercatezza che li pervade, sono di dimensioni contenute, fatti sempre su carta, quadrettata.
Un'opera di Harloff.
Nascevano come minuziose composizioni, a biro, matita, pennarello. Venivano poi i colori, patinati con gomme arabiche, cere e altri materiali. Nelle opere di Harloff compaiono le figure e le allegorie base di tutte le civiltà: la ruota, il triangolo, il cono, il cerchio, la spirale, accanto a strutture, invece, puramente inventate. Il mistero che ne scaturisce deriva dal loro essere tutte in relazione le une con le altre, in rapporti mai arbitrari, ma che richiamano gli arcani legami pulsanti nell’universo oltre l’evidente. Quell’evidente che dobbiamo superare per consegnarci alle baudelairiane corrispondenze. È proprio qui che possiamo spingerci per cogliere il segreto che vibra oltre l’ovvietà.