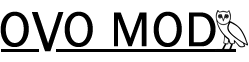Ci si chiede spesso quale sia il metro di giudizio per definire il valore di un progetto fotografico. Potrebbe essere la frequenza con cui viene
Ci sono fotografi che lavorano anni sui loro progetti e in quei casi la relazione con il tempo si complica ulteriormente, diventando una componente fondamentale della storia che vogliono raccontare. C’è una specie di “certificazione di validità” per quei lavori che vengono portati avanti così a lungo. Crescono nel tempo e il fotografo cresce con loro. È facile riconoscerli: dietro ogni immagine c'è come uno spessore trasparente; è il tempo impiegato a osservare, comprendere, analizzare ciò che si fotografa – e in fondo, anche se stessi. I progetti a lungo termine che funzionano hanno una caratteristica impossibile da falsificare: rimangono sempre, inevitabilmente, attuali.
Il lavoro di Nicola Lo Calzo è uno di questi. Da più di dieci anni, il fotografo italiano documenta l’eredità della schiavitù in vari paesi del mondo: Benin, Togo, Ghana, Senegal, Haiti, Cuba, Stati Uniti e anche in Italia. Attraverso una ricerca sociale e antropologica, Lo Calzo scava nel sottobosco di storie dimenticate e le rende accessibili attraverso il linguaggio delle immagini, svelandoci un passato storico omesso nei libri di scuola.
Nel suo ultimo progetto, Binidittu, Lo Calzo prende in esame i rapporti fra la storia del colonialismo e l’identità culturale contemporanea attraverso la figura di San Benedetto il Moro, frate minore vissuto in Sicilia fino alla sua morte (1589). La figura di Binidittu, tutt’ora patrono della città di Palermo e oggetto di un culto ben radicato in Sicilia, non solo è stata eletta a protettore sia degli afro-discendenti in America Latina sia dei Palermitani, ma è diventata anche icona di riscatto ed emancipazione a livello mondiale. Ripercorrendo le tappe principali della biografia di Binidittu (dall’affrancamento dalla schiavitù alla sua morte, dall’utopia post razzista alla beatificazione), Nicola Lo Calzo traccia un parallelismo sottile con la condizione di invisibilità che sperimentano sulla propria pelle molti afro-discendenti ancora oggi.
Oltre ai materiali d’archivio e alla documentazione dei luoghi e dei segni che parlano di San Benedetto, Lo Calzo ha infatti incluso nel progetto alcuni scatti realizzati a Palermo in collaborazione con giovani ragazzi di origini africane, mettendo in moto una riflessione sul nostro passato coloniale e sulle implicazioni che ha avuto – e ha tutt’oggi - nella costruzione dell'identità di intere nuove generazioni.
Il progetto, pubblicato sotto forma di libro da L’Artiere Edizioni, è esposto fino al 18 luglio a CAMERA Torino e dal 30 luglio al 29 agosto al festival Images Gibellina.
Abbiamo incontrato Nicola Lo Calzo che ci ha raccontato di più sul progetto.
Come è nato il progettoBinidittu?
Questo progetto nasce da una ricerca che conduco da dieci anni sulle memorie della schiavitù nel mondo atlantico e mediterraneo, un lavoro più ampio che si riunisce sotto il titolo Cham. Ho incontrato la figura di San Benedetto il Moro in America Latina, lavorando sulle comunità afro-discendenti. Durante le mie ricerche mi sono imbattuto in un certo San Benito de Palermo e da lì a breve ho capito che si trattava di una figura storica, religiosa e politica le cui origini erano più lontane geograficamente: Binidittu è un uomo afro-italiano vissuto nella Sicilia del 500, figlio di schiavizzati Africani, canonizzato in seguito come San Benedetto il Moro, il cui culto è tutt’ora praticato in Sicilia e in America latina. Lavorando nel mondo atlantico, tra i Caraibi, la Guyana, il Suriname, Haiti e l’America del Sud, era da tempo che aspettavo una storia importante che potesse permettermi di tornare a casa. In qualche modo credo che la figura di Binidittu mi abbia permesso di ricongiungere il mondo atlantico e quello mediterraneo, attraverso una ricerca fotografica che interroga innanzitutto le contraddizioni della società in cui viviamo e ci muoviamo oggi: partire dalla memoria di Benedetto, la sua eredità culturale e simbolica, e cercare di costruire un ritratto contemporaneo della nostra società, attraverso un prisma decoloniale. Nella mia pratica artistica, mi interessa raccontare la risposta dei gruppi subalterni ai meccanismi della violenza coloniale, che ha lasciato delle tracce concrete nei rapporti di potere (colonialità), nel razzismo sistemico, e nelle pratiche culturali di alcune comunità. Detto questo, il mio lavoro si concentra in particolar modo sulle produzioni culturali che sono nate in risposta alla schiavitù e alla tratta dei subsahariani. Ovviamente dietro queste produzioni culturali di grande vitalità permangono delle situazioni di fragilità e di discriminazione che, nelle mie foto, restano in filigrana, volutamente in secondo piano. In fondo, ciò che mi interessa é raccontare la complessità, la bellezza e la ricchezza culturale che si è prodotta a fronte di questa violenza originaria che é stata la schiavitù.
La figura di Benedetto ha assunto molti “volti” e molti nomi nel tempo: da santo locale in Sicilia a figura ribelle in America Latina. Mi racconti di più?
La vicenda di San Benedetto il Moro mi ha subito affascinato, così come la devozione dal basso verso quest’uomo afro-discendente. Il popolino palermitano gli dedicò un culto quando era ancora in vita, accorrendo al convento di Santa Maria di Gesù per chiedere consigli, aiuti e guarigioni, e ben duecento anni prima che fosse iscritto al martirologio romano (nel 1807, si tratta di uno dei processi di canonizzazione più lunghi della storia della Chiesa). Alla sua morte (1589), l’aristocrazia spagnola – all’epoca la Sicilia era un dominio spagnolo – realizza che la figura di Benedetto poteva essere un potente strumento di evangelizzazione per le popolazioni schiavizzate nelle giovanissime colonie americane. Sulle navi in rotta per il “nuovo mondo”, e al braccio dei missionari francescani, le statuette del santo nero arrivano in America Latina, dove gli uomini e donne schiavizzati, dietro alla sua parvenza calma e pacifica, l’aria quasi sottomessa, riconoscono in Benedetto una figura di resistenza e di potere. Lo adottano da subito come figura di libertà, un ribelle dalla faccia d’angelo. Del resto nelle piantagioni, l’unico modo per sopravvivere era fuggire o far finta di obbedire. Il santo siciliano è quindi sincretizzato con gli orishas africani e poco a poco si creolizza sino a diventare quello che è oggi, ovvero il protettore degli afro-latinos. Il culto di Benedetto diventa globale e atlantico.
Al contrario, in Sicilia Benedetto rimane una figura di santità locale nella più autentica tradizione cattolica. Da una ventina d’anni, si assiste a un fenomeno nuovo e Binidittu si carica progressivamente di nuovi significati, assurgendo a simbolo di lotta contro il razzismo. Al mio primo soggiorno in Sicilia nel 2017, era da poco stato realizzato il murales di Igor Scalisi Palminteri raffigurante San Benedetto il Moro nel quartiere di Ballarò. Diversi sono gli artisti che da allora lavoravano su questa figura poliedrica e moderna, penso al lavoro di Martino Lo Cascio con cui ho collaborato nell’ambito del progetto Binidittu. Questo processo di riscoperta é nato alla fine degli anni ’90 sotto la spinta di Leoluca Orlando, che, diventato sindaco di Palermo, rilancia la figura di Benedetto a livello locale, e con esso il culto, iniziando a partecipare ogni anno alla processione che ha luogo nella borgata di Santa Maria di Gesù. Benché co-patrono dimenticato di Palermo, San Benedetto il Moro diventa una figura più conosciuta dai palermitani a partire dagli anni 90.
Come è percepita la figura di San Binidittu in Sicilia?
La comunità di devoti siciliani ha in qualche modo smarrito nel tempo, per una serie di ragioni storiche e politiche, la genealogia africana o subsahariana del santo. Lo percepisce non più come un santo nero e africano, come avviene nell’America latina, dove Benedetto è chiamato Santo Preto o San Benito el Negro. É interessante notare che delle contraddizioni emergono nel modo in cui alcuni devoti lo vedono e lo concepiscono. All’inizio la tentazione é stata di pensare a una sorta di white washing, poi, col procedere delle interviste, mi sono reso conto che stavo applicando una prospettiva americana a una realtà mediterranea e così specifica quanto é quella siciliana: una terra fatta da un popolo risolutamente meticcio, che, non dimentichiamocelo, è stato razzializzato e stigmatizzato fino a tempi molto recenti. Ho pensato alle teorie pseudo-scientifiche di Cesare Lombroso, ho pensato all’insulto spaghetti-niggers con cui erano chiamati i meridionali (siciliani, napoletani, calabresi) nei bassifondi di New Orleans o di Brooklyn, ho pensato agli studi antropometrici fatti subire ai meridionali dall’Unità d’Italia fino ai primi del 900 e ho preso la misura di quanto fosse riduttore applicare questa logica binaria e moralista del mondo a una realtà complessa come quella siciliana e italiana. Credo che le vere ragioni per cui questo santo è ora concepito a tutti gli effetti come un santo locale siano dovute prevalentemente a due fatti storici: da un lato, con l’emergenza dello schiavismo e della tratta atlantica ai primi del 600 (diventerà sistema economico industriale solo nel 700) il baricentro dell’economia occidentale si sposta dal mediterraneo all’atlantico: la popolazione afro-discendente presente in Sicilia e nel bacino mediterraneo diminuisce progressivamente fino a fondersi con il resto della popolazione lasciando poche tracce visibili nella genealogia. La presenza storica di uomini e donne subsahariani fu così dimenticata. Dall’altro, nel nuovo scenario geopolitico internazionale che si apre con il XVIII secolo, il “santo schiavo” rappresenta, agli occhi delle élite ecclesiastiche e secolari, un modello proto-abolizionista che restituisce all’uomo nero la sua piena umanità, elevandolo addirittura a beato, nel momento stesso in cui si costruisce l’ideologia della razza. In Sicilia, già alla metà del Seicento, la figura di Benedetto perde d’importanza a favore di nuovi modelli di santità più vicini alla quotidianità dei devoti (Santa Rosalia).
Questo progetto ha anche questa ambizione: farci riflettere sul fatto che la presenza africana in Italia è una presenza storica e non il risultato di un fenomeno di immigrazione recente. Si tratta di un processo storico, di cui Benedetto rappresenta una delle figure meglio preservate, benché sia pressoché sconosciuto dal grande pubblico. In questi termini, il mio lavoro desidera contribuire a decolonizzare e decostruire la visione che abbiamo della nostra Storia nazionale, raccontata spesso nei manuali scolastici come un processo lineare e escatologico. attraverso un pantheon d’eroi nazionali che, oggi più che mai, necessita di essere rivisitato, ampliato e completato. San Benedetto il Moro è uno di questi nostri eroi dimenticati. Stiamo vivendo un periodo effervescente in cui i riflettori si stanno finalmente accendendo sui margini della nostra storia comune e questo anche grazie all’impegno di numerosi artisti e attivisti italiani, penso al lavoro della scrittrice Igiaba Scego che ha scritto un testo per il libro Binidittu recentemente pubblicato dall’Artiere.
Dopo tanti anni sei tornato in Italia. Come è stato lavorare in Sicilia?
Come è normale che succeda, sono arrivato con una visione che poi non corrisponde all’esperienza che si vive. In primis, avevo una serie di preconcetti anche rispetto al fatto che avevo lavorato molto a contatto d’artisti e attivisti americani che guardano il mondo a partire dalla loro posizione e dai loro traumatismi sociali (lo schiavismo americano, la segregazione razziale, il razzismo sistemico, l’incacerazione di massa). Benché il loro apporto è stato fondamentale nella costruzione della mia visione del mondo e anche della mia fotografia ( il testo pioniere della letteratura afro-americana Invisible Man di Ralph Elisson accompagna le fotografie nel libro Binidittu), credo che oggi sia fondamentale pensare il mondo a partire dalle sue specificità locali senza cadere in griglie di letture preconcette o categorie di pensiero binarie. Solo in questo modo, si può produrre a mio avviso una fotografia critica e contestualizzata, per l’appunto decoloniale. Proprio qualche giorno fa la scrittrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie in una intervista rilasciata al The Guardian metteva in guardia le nuove generazioni dall’adottare questa visione moralizzante e esclusiva del mondo (che rischia di produrre nuova esclusione).
La Sicilia è una terra che storicamente si è costruita attraverso apporti mediterranei, sia europei che africani, e in questo progetto ho voluto far emergere queste molteplici origini, e filiazioni. A livello di pratica fotografica, all’inizio ho avuto delle difficoltà anche legate al mio personale. Era molto tempo che non lavoravo in Italia e in un certo senso avevo una certa apprensione a ritornarci. Sapevo che lavorare in Sicilia sarebbe stato un po’ come confrontarmi con quel mondo da cui ero fuggito 15 anni prima alla ricerca della mia storia. In realtà è stato un bel confronto, all’inizio sono stato accolto con un po’ di diffidenza che ha lasciato spazio all’accoglienza e alla partecipazione sia da parte delle comunità di devoti, che dai ragazzi immigrati, che dagli attivisti con cui ho lavorato….
Inoltre, il ritorno in Italia è anche essere qui oggi a CAMERA nella mia città, con questo progetto e questa mostra curata da Giangavino Pazzola.\
Quanto tempo hai lavorato su questo progetto?
Ho iniziato nel 2017 e poi sono tornato più volte rispettando il calendario religioso delle celebrazioni legate a Benedetto. Ho lavorato su due mondi paralleli: il mondo dei devoti e il mondo della diaspora africana. È stato un lavoro di ricerca fatto in collaborazione con gli storici locali, penso a Alessandro dell’Aira, a Giovanna Fiume, alle confraternite di San Benedetto e ai centri d’accoglienza, come il Porco rosso o il Centro Astalli. Ho vissuto per esempio al convento di Santa Maria del Gesù, dopo aver negoziato a lungo con i francescani che alla fine mi hanno generosamente accolto. Ho avuto l’onore di dormire a qualche passo dalla cella di Benedetto. É stata un’esperienza mistica poter connettermi con i luoghi della sua vita. Del resto, il progetto generale Cham ha una dimensione mistica: la memoria della schiavitù è stata trasmessa sopratutto all’interno di pratiche religiose.
Una parte diBinidittuè dedicata ai giovani afro-discendenti che vivono in Sicilia. Qual è il loro ruolo all’interno del progetto?
Il mio lavoro cerca di porre alcune domande sull’idea di visibilità e invisibilità. Cosa significa oggi essere visibili e invisibili in un contesto come quello siciliano? Per cercare una risposta ho lavorato con alcuni ragazzi alcuni dei quali conoscevano già Benedetto. Tra i tanti Kanake Julia Nkatha, Abibata Konaté, Mamadou Oury Diallo, Kanake Victoria Gatwiri, Idrissa, Hatar Lahman, Chamwill Njfon, Mohammed, Nadia Naspallah, Omar Silah, Mamadou Diallo, Ibrahim, Bakary, Berete Mohamed Ayouba, Moussa Sangare, Ismaila Kouyata, Yodit Abraha, Ernest, Abdul, Mustafa, Ibrahim, Lasso et altri. Dietro ogni "scatto", la qualità della relazione tra il fotografo e il suo soggetto può tendere verso una verticalità o verso una orizzontalità. Ogni fotografo costruisce le sue fotografie su questa tensione, producendo immagini più o meno verticali o più o meno orizzontali. La mia ambizione é realizzare immagini che siano il più orizzontali possibili. Nel caso di Binidittu, il fatto che la maggior parte delle persone da me fotografate siano giovani artisti ha giocato molto nella costruzione delle immagini e mi ha permesso di realizzare delle fotografie in equilibrio tra verità e fiction. Questa ambiguità dell’immagine è ciò che m’interessa perché lascia aperta la possibilità a molteplici interpretazioni oltre al mio punto di vista. Detto questo, il mio lavoro é documentario: passare un certo tempo con le persone che ritraggo mi conduce verso situazioni improbabili e impreviste che hanno l’apparenza della fiction mai che di fatto restano situazioni reali.
Da dove deriva il tuo interesse verso le tematiche della schiavitù?
Mi sono avvicinato al tema dello schiavismo e della sua memoria a partire dalla mia formazione di storico-conservatore dei beni culturali e architetto. La nozione di patrimonio e di “monumentum” è stata sempre fondamentale in tutto il mio percorso artistico.
Inoltre, il fatto che io sia queer, e quindi cresciuto e evoluto in una situazione di minoranza, é stato un motore in più a spingermi verso queste problematiche: capire come le minoranze, siano esse di genere, origine o appartenenza diverse, costruiscano la propria cultura, identità e memoria. Lavorando su questi temi spesso mi sono reso conto che mi trovavo di fronte a delle pratiche e dei patrimoni immateriali pressoché sconosciuti dal grande pubblico. È stato un lavoro sperimentale che ho costruito a partire da una ricerca storica e antropologica precisa, cercando di restituire per immagini una storia e una memoria che non era ancora stata raccontata, ad eccezione dell'ambito accademico o letterario. La mia è una fotografia metastorica che ha un valore politico, nella misura in cui desidera rendere accessibile a un pubblico non necessariamente specializzato, delle memorie locali e marginali. I media e i giornali mi hanno permesso, ancor prima delle mostre, di diffondere a un audience generico delle storie che fino a qualche anno fa interessavano solamente agli addetti ai lavori.
Tu, Nicola Lo Calzo, cosa hai imparato da questo progetto? Qual è l’esperienza personale che ti porti dietro?
Sono quattro anni che lavoro sulla figura di Benedetto, quindi ormai considero la sua storia anche un po la mia. La ragione per cui sono fotografo è la possibilità di esistere nella relazione con l’altro ( per usare le parole d’Edouard Glissant, il mio mentore spirituale) e ogni scatto corona in qualche modo un singolo incontro. In quanto persona queer, la fotografia è stata ed é un percorso personale di emancipazione in un mondo pensato e disegnato per una maggioranza eteronormata. Ricordo che prima de tenere in mano una macchina fotografica, avevo non poche difficoltà a guardare le persone dritte negli occhi. La fotografia mi ha aiutato a stabilire quel contatto orizzontale fondamentale con la persona davanti a me e a liberarmi progressivamente dalle mie paure. Ancora oggi, affrontare lo sguardo degli altri è un rituale, una liberazione che compio e rinnovo a ogni scatto. Si é trattato di un viaggio personale sulle rotte della tratta degli schiavi, nelle ferite di questa violenza fondatrice. Ho celebrato i vengeurs de ce monde a Haiti, ho ascoltato i Dieux d’Afrique nel Dahomey, ho condiviso il dono dell’Obia in Suriname. Numerosi sono stati gli amici e gli incontri ad accompagnarmi scrupolosamente e anche forse a proteggermi in questo viaggio iniziatico tra l’Africa, i Caraibi e le Americhe per ritornare in seguito al mio paese natale, l’Italia. Desideravo immergermi nel vivo di queste pratiche per tentare di conoscerle. Ho scelto di pormi dietro la macchina fotografica, che per me è diventata il primo mezzo di conoscenza e di comprensione del reale. In fondo, più che delle belle immagini, cercavo a reinventarmi attraverso nuove identità e appartenenze, oltre al senso più profondo della mia esistenza: la mia relazione al mondo.
Che si appartenga a una minoranza o no, il fatto di lavorare con delle comunità subalterne ci obbliga ad essere coscienti da dove si parla, da dove si esprime, da dove si fotografa. Durante il mio dottorato di ricerca a Parigi, sto proprio lavorando sugli usi possibili della fotografia “situata”, ovvero una fotografia che tenga conto della posizione da cui il fotografo si esprime. Assumere questo punto di vista ( da dove si parla) è a mio avviso la condizione fondamentale per poter raccontare oggi la complessità di una comunità, e avvicinarsi il più possibile al punto di vista del leone secondo il proverbio africano: “Fino a quando i leoni non avranno i loro storici, la storia sarà scritta alla gloria dei cacciatori”. Mi piace questo proverbio perché la figura del leone, nonostante sia di fatto in una condizione di dominato rispetto al cacciatore, non rappresenta una figura avvilente, né tantomeno una vittima. In Italia ci sarebbe da fare un grande lavoro sulla storia marginalizzata, quella che è rimasta fuori dai libri di storia. Ci sono state tante altre storie come quella di Benedetto che andrebbero raccontate.